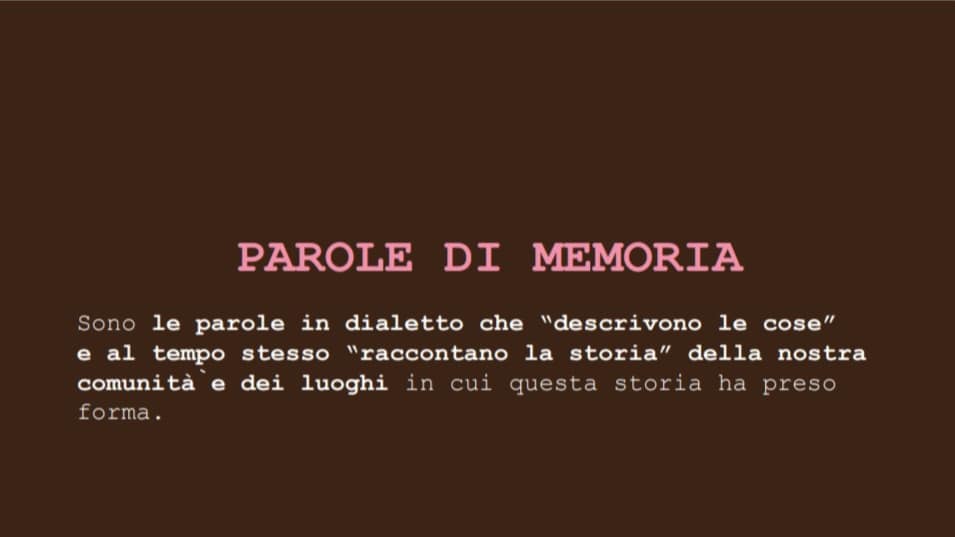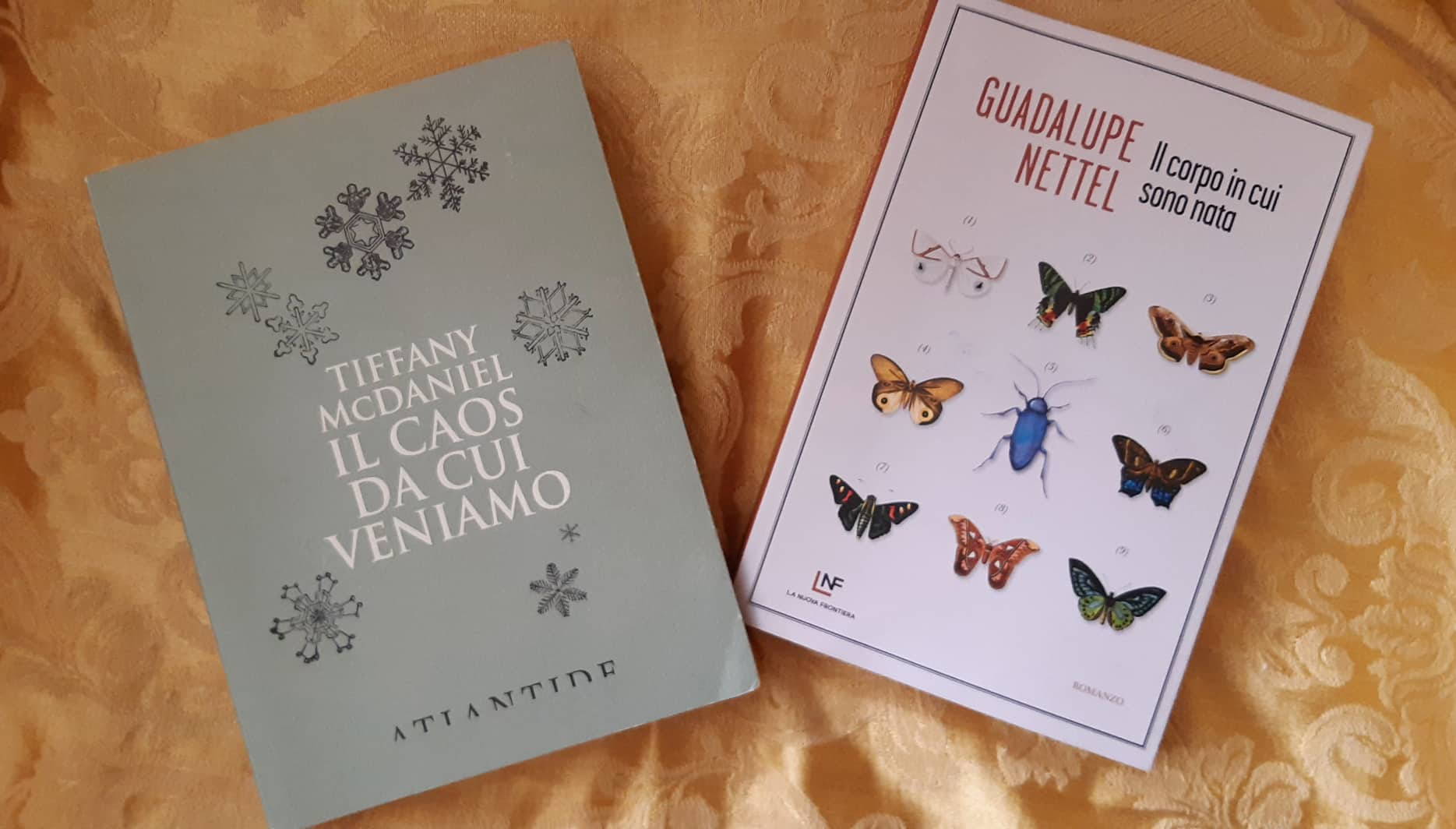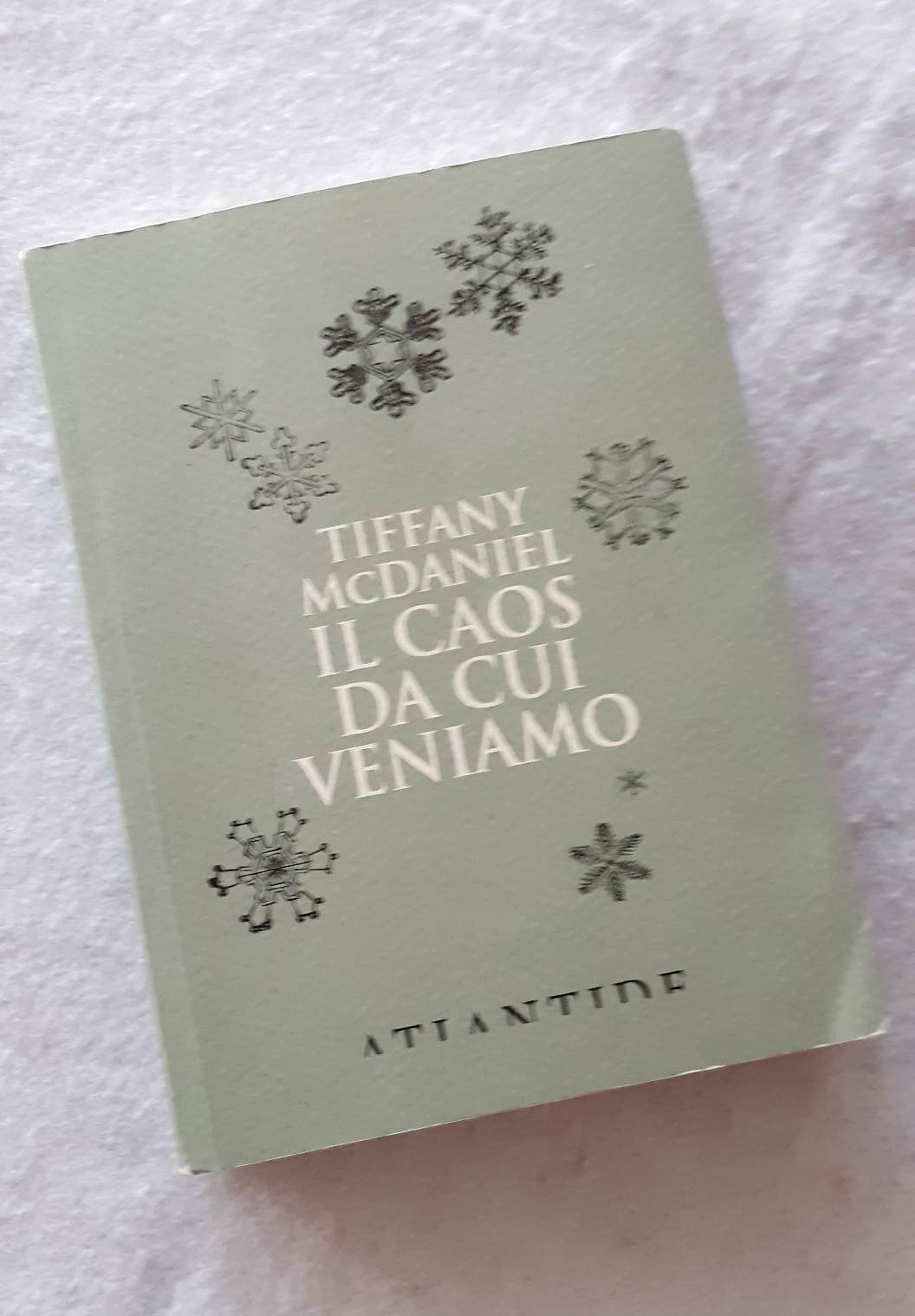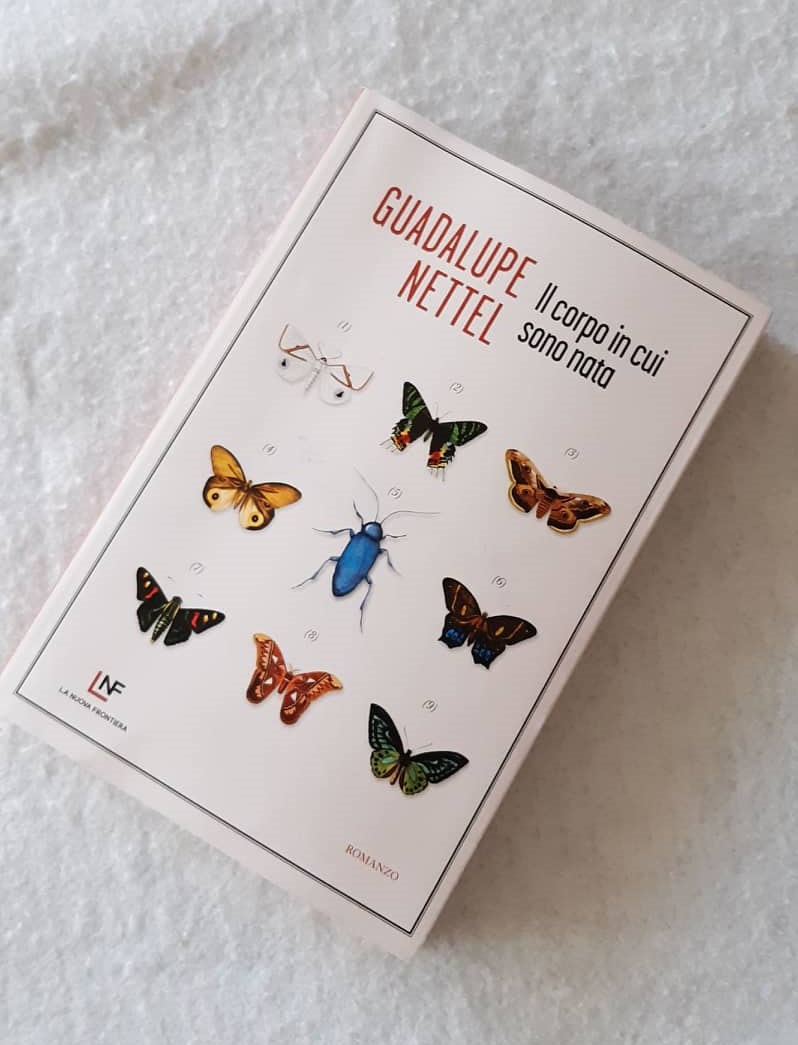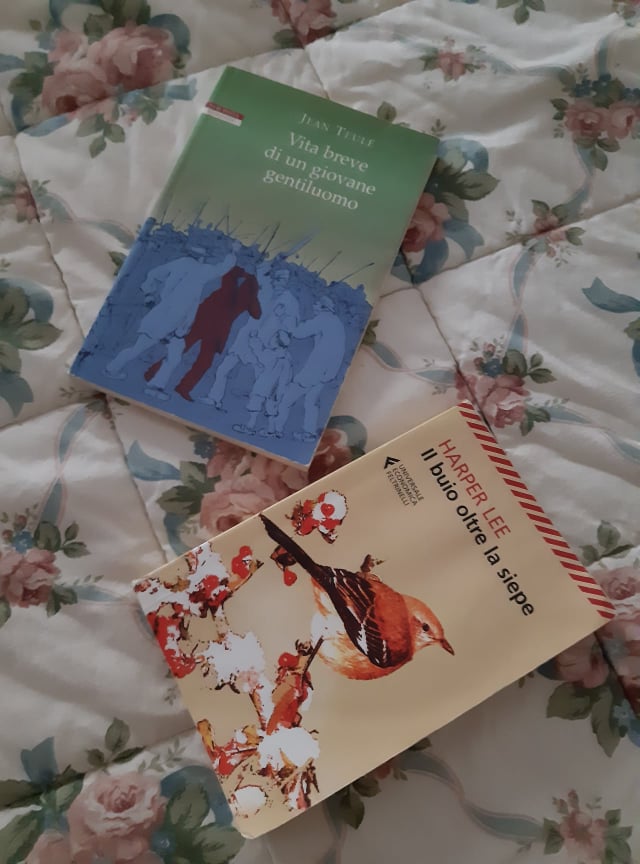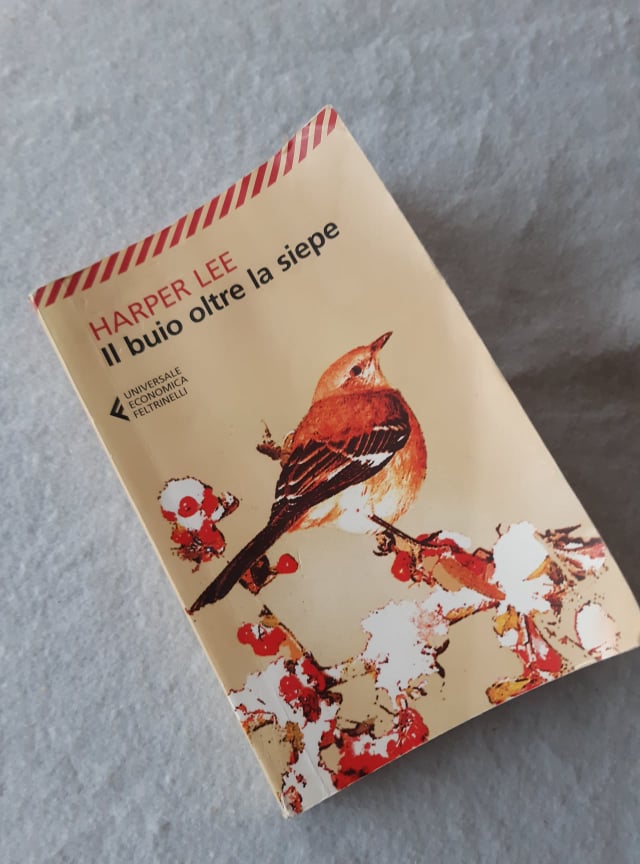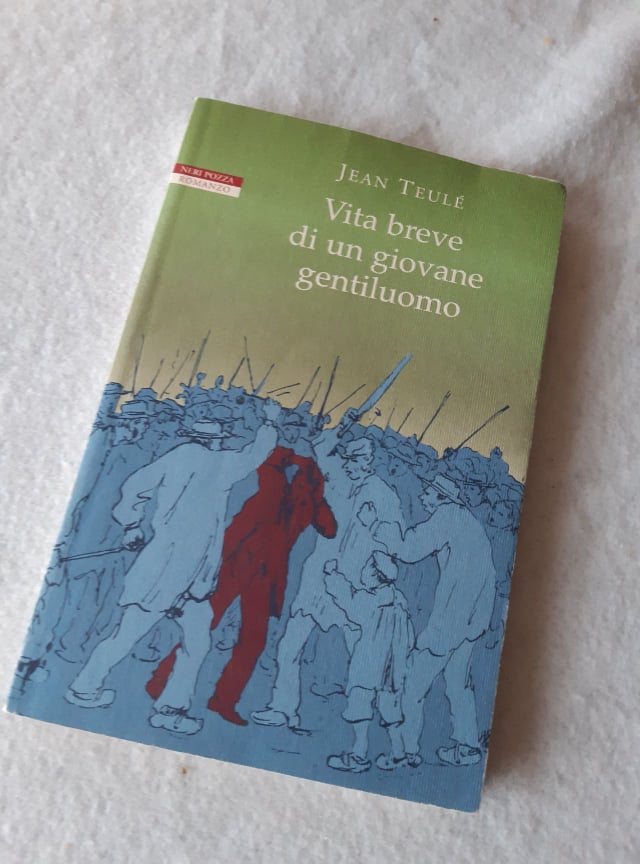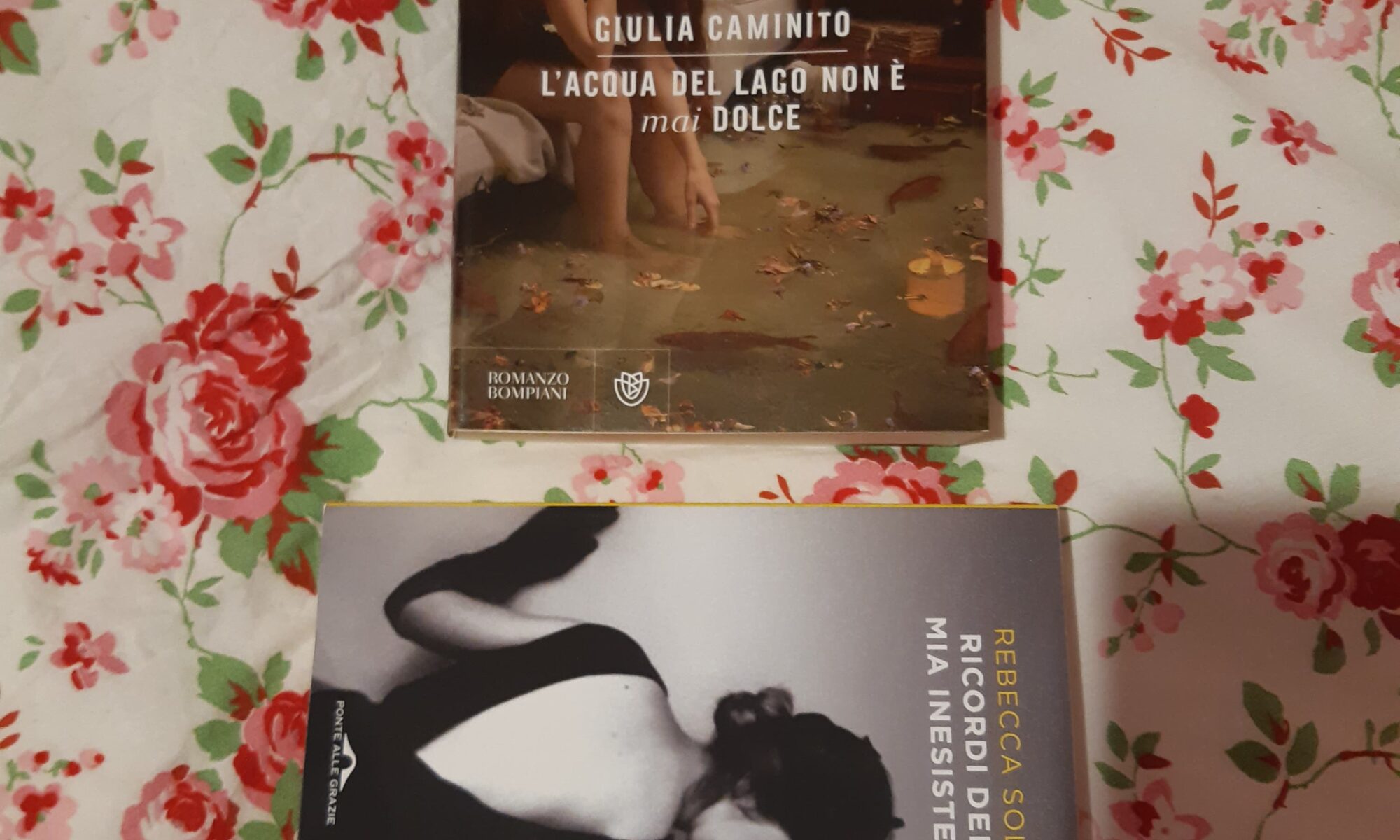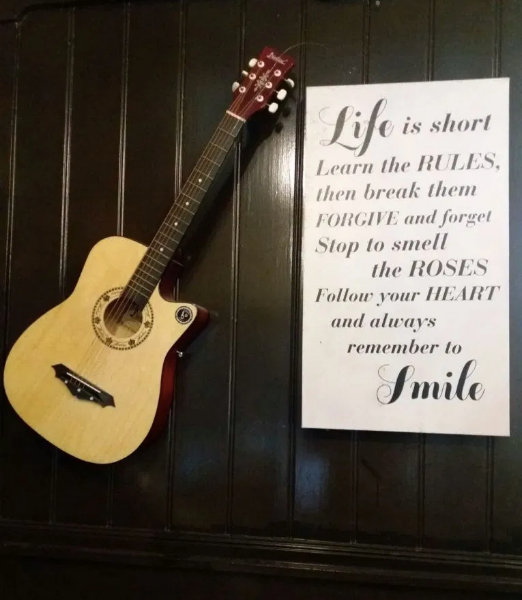Buon Natale 2023
Mia nonna, nei suoi ultimi giorni, a letto, alternava momenti di lamento profondo per i dolori, a sonno comatoso, a racconti di ricordi ispiratissimi.
I ricordi che mia nonna raccontava riguardavano una vita di 96 anni e qualche mese, iniziata negli anni ’20 del secolo scorso, in un piccolo paese della provincia di Frosinone, il mio, in una famiglia composta da un padre medico “condotto” (come sempre sentivo dire da lei), una mamma dal carattere di una “battagliera” (la mia longeva bisnonna di oltre 20 anni più giovane del marito) e già due sorelle e un fratello ad aspettarla, mentre un altro fratello sarebbe arrivato due anni dopo di lei.
Tutti i fratelli sono sempre stati un elemento centrale nei racconti di mia nonna, rimasta orfana di padre all’età di 4 anni. “Fratone” il suo fratello maggiore, medico poi emigrato negli Stati Uniti e il suo fratello più piccolo, amatissimo, morto prematuramente. Ma ho sempre pensato che i super -poteri di mia nonna fossero le sue sorelle maggiori, “le sorelle” come le chiamava, diversissime da lei, e in particolare una delle due, “la sorella” (mia nonna anche lei), con cui ha vissuto insieme tutta la vita, avendo sposato a loro volta due fratelli (motivo per cui io ho avuto quattro nonni materni di fatto e, al netto della difficoltà a spiegare l’albero genealogico, ho sempre considerato questo un gran bel regalo che la vita mi ha fatto).
Più o meno adolescente, mia nonna, sola tra le sorelle, è stata mandata a studiare a Perugia, in un collegio statale per orfani di medici, sezione femminile.
Del suo tempo a Perugia, mia nonna mi raccontava con estrema precisione di particolari, i nomi e l’aspetto delle sue amichette, le dinamiche in classe, le materie e gli argomenti che le davano ansia e i modi che trovavano per superarle, i loro giochi con niente, l’acqua ghiacciata che usavano per lavarsi la mattina, l’inventiva per far bastare beni di prima necessità che scarseggiavano anche nel collegio. Mi raccontava, senza mai dirlo (mia nonna non parlava direi mai di sentimenti né di emozioni) la solitudine di una bambina, in un posto freddo, severo e lontano dalle sua famiglia ma soprattutto dalle sue sorelle. Mi raccontava che a Natale e a Pasqua le ragazzine che abitavano più lontano, non tornavano a casa.
Quando stava per morire, un giorno in particolare mia nonna ha fatto una selezione di ricordi, mi ha raccontato solo le cose belle della sua vita, e quasi tutte erano legate all’infanzia . E avevo l’impressione che non le stava raccontando a me, le stava “vedendo” e toccando, incontrando di nuovo. Lo posso dire dalla luce dei suoi occhi e dalle lacrime di gratitudine che ho visto scendere sulle sue guance, rimaste sempre tondette come quelle di una bambina.
In particolare, quando mi raccontava del Natale, nel collegio di Perugia con le poche altre bambine che come lei non tornavano a casa. All’improvviso ha spalancato gli occhi e ha esclamato, con quella sua giustapposizione, tipica di italiano e dialetto: “I sosemeglie! Quando arrivavano i sosemeglie!“, come se fosse il giorno più bello della sua vita. “Le sorelle mi mandavano il pacco co’ gli sosemeglie. La direttrice mi chiamava “Valente”, e io lo andavo a prendere. Era il pacco co’ gli sosemeglie di Natale! Le sorelle lo legavano con un fiocco, di spago. Io lo prendevo, lo portavo in camera, lo aprivo e davo subito uno a Maria (la sua amica del cuore, ndr), uno me lo mangiavo e poi li conservavo“.
Mentre parlava, muoveva le mani per toccare il pacco, per sciogliere il fiocco, e per conservare il primo sosemeglio sul cuore.
Io un amore così invisibile e così profondo, nel tempo e nello spazio dei mondi, non so se l’ho mai rivisto.
Ma questo, di certo, è l’augurio che vorrei fare per Natale.
Questa gratitudine e questa forza di navigare i secoli, che viene dalla capacità di vedere “oltre” il visibile.
Oltre un pacco di sosemeglie, legato da un fiocco di spago, tutto l’Amore che c’è.

Tra le cose più incredibili a cui ho assistito fin qui, citerei gli ultimi giorni di vita di mia nonna. Ho visto la grazia di chi sta per lasciare questa vita per andare non so dove, e ho visto gli occhi spalancati e illuminati, di chi (ri)vede davanti quello che è stato indietro. Ci sono sguardi che vedono quello che ancora non è perché già lo hanno visto, e ho l’impressione che questo miracolo sia l’esperienza dell’amore su questa terra.
buon Natale 2023
ChiaraB.
#paroledimemoria “gli sosemeglie“: biscotti natalizi della tradizione corenese.
Sulla ricetta di questi biscotti, abbiamo bisogno di aiuto. So che sono biscotti duri, fatti con miele, noci e a volte cioccolato. Grazie a chi ci aiuterà a essere più precisi!
Cosa sono le #paroledimemoria e tutte quelle incontrate fin qi le trovi nella categoria “Parole di memoria“