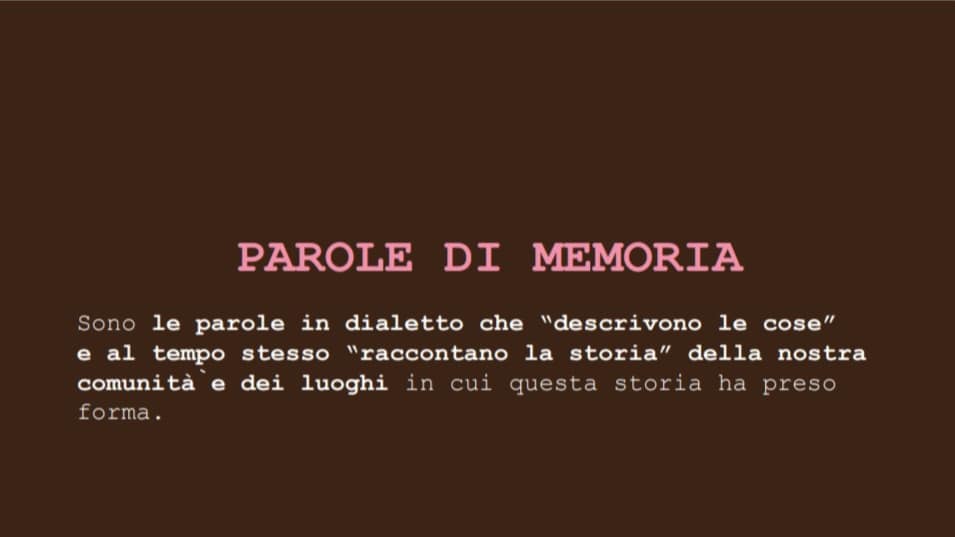Riflessioni sul ruolo del dialetto per identità in transizione*.
Transizioni e identità
Viviamo un tempo di transizioni, siano esse processi naturali e culturali “de facto” o “programmi” politicamente disegnati e finanziati.
Pensiamo agli stravolgimenti geologici, per cui si parla della nostra come dell’era dell’Antropocene, in cui l’essere umano con le sue attività è arrivato a incidere sul livello territoriale, strutturale e climatico. Pensiamo alla transizione a cui il Covid e post-Covid ci ha condotti, e pensiamo al terremoto geo-politico ed energetico che la conclamata emergenza climatica sta sollecitando da anni e di cui la guerra, che si consuma su suolo ucraino, ha accelerato gli impatti, ormai in atterraggio violento sulle economie reali dei nostri territori. Pensiamo infine alle grandi trasizioni europee, cd transizioni gemelle, verde e digitale, la cui piena realizzazione, nella visione di Bruxelles, è prerogativa di futuro per lo stessso progetto di Unione europea. Dare “piena realizzazione” a tale transizione implica renderla inclusiva e giusta, preservando dallo scotto del cambiamento sistemico i territori meno preparati al grande salto della digitalizzazione e della neutralità climatica su ampia scala, ovvero ad azzerare l’impatto ambientale da qui al 2050 attraverso la trasformazione di sistemi produttivi, filiere di distribuzione e consumo, stili di vita. Come cambia l’uomo in questo monumentale transitare? Come cambia il sentire la comunità come “propria” e se stesso come parte di una comunità? Che confini ha la comunità dell’uomo delle transizioni? E dove àncora la sua identità? Quali parole la descrivono, la evocano, permettono di riconoscersi ancora simile ad altri, all’interno di un perimetro geografico-culturale? Che valenza ha il territorio nell’accompagnare il singolo e la comunità nella “dovuta” transizione, se è vero che la trasformazione dei contesti, prima che da risorse pubbliche o investimenti privati, passa dalle aspirazioni degli abitanti e dal loro ruolo attivo e in una qualche misura imprenditivo? (Venturi, Zandonai 2019) Domande enormi, a cui tante analisi e punti di vista arrivano a proporre “pezzi”, si spera integrati, di prospettiva. La nostra prospettiva parte da un territorio del basso Lazio e dal suo dialetto, con l’inizativa in erba “Parole di memoria”. Un progretto piccolo, familiare quasi, con un respiro che aspira alla profondità delle radici di cui si nutre.
Parole di memoria, recuperare nel dialetto tracce di identità
“Parole di memoria” nasce da una domanda in parte controintuitiva in tempo di transizione. Si prefigge infatti di usare le parole del dialetto e il loro ancoraggio fisico, quasi il loro manifestarsi visivamente nei luoghi reali del territorio, per contribuire a spostare la riflessione dal più urgente “dove stiamo andando”, al più lento “da dove veniamo” ovvero “quale antropologia stiamo lasciando dietro di noi”. La consapevolezza della memoria ci regala la libertà di scegliere cosa portare verso il nuovo mondo. Una transizione libera ha in sé un esercizio di tradizione, nel senso etimologico del termine, del “trasmettere”, per poter conservare ciò a cui si riconosce un valore, attraverso un esercizio di memoria e di narrazione che usi la lingua che più di altre ha dato forma all’identità territoriale e comunitaria nel tempo e nello spazio: il dialetto. In questo senso abbiamo scelto di interrogare le parole della piccola storia del nostro paese: le Parole di memoria di Coreno Ausonio (FR). “Passeggiare e pensare in natura attraverso le stagioni. Spesso lo faccio in compagnia di mio padre e nel camminare seminiamo memoria, per chi vorrà raccoglierla. Siamo a Coreno Ausonio, accovacciati tra i monti Aurunci, affacciati sul golfo di Gaeta, a 318 metri sul livello del mare, in provincia di Frosinone. Qui è passata la Storia attraverso i secoli, ha fatto sosta la Seconda Guerra Mondiale, lasciando il tracciato della Linea Gustav con il suo sangue, il suo dolore e le storie indelebili. Ogni volta che camminiamo incontriamo delle parole, pezzetti di storie che ricomponiamo, pezzetti di noi”.
“Parole di memoria” sono dei video in cui raccogliamo, dalla memoria di mio padre (classe 1944), le parole in dialetto, cerchiamo di spiegarne il significato e raccontiamo le tradizioni e le storie della comunità corenese e della civiltà rurale che a quelle parole sono collegate. Le Parole di memoria vengono fuori quasi “spontaneamente” mentre camminiamo, un po’ come la stramma, come gliu ventriscu (lentisco) e come le scocciacannate (ciclamini) ai bordi della strada. Sono le parole in dialetto che “descrivono le cose” e al tempo stesso “raccontano la storia” della nostra comunità e dei luoghi in cui questa storia ha preso forma. Riguardano gli eventi belli, la vita di tutti i giorni e le tragedie familiari e universali di cui siamo stati testimoni, anche attraverso i nostri antenati. Attraverso le Parole di memoria recuperiamo non solo la memoria storica e culturale del paese ma anche antropologica, ovvero lasciamo che emerga “l’umanità” che nella comunità si alimentava in modo quasi viscerale, come a definire il dna dei corenesi. Ci piacerebbe che fosse un racconto non solo evocativo ma, nel suo piccolo, generativo di piccoli semi di memoria ma anche di futuro: di quello che siamo stati, che in parte siamo ancora e che possiamo scegliere di tornare a essere, pur nelle forme e nei ritmi della nostra contemporaneità.
Il dialetto di Coreno Ausonio, chiedere ai luoghi “chi sémo”?
“Parole di memoria” raccoglie schegge di dialetto corenese, ritrovate camminando nella campagna e tra le strade del nostro paese che “non è” provincia di Caserta, “non è” Ciociaria, “non è” provincia di mare (Latina), ma confina con le tre aree e nel suo dialetto ne riceve gli influssi, sia in termini morfosintattici che lessicali e fonetici, nonché di codici extralinguistici. Coreno Ausonio ha infatti una forte identità dialettale, legata a un certo attaccamento a tradizioni e cultura di appartenenza, queste ultime simili eppure diverse e specifiche rispetto ai paesi confinanti. Questo fa sì che il “corenese” sia percepito un po’ come una seconda lingua, secondo un modello diglottico. Interessante notare come, sia a livello familiare che comunitario, si stia sviluppando una sorta di semi – dialettofonia di ritorno, collegata a un rinnovato interesse culturale per tutto ciò che è più puramente “corenese”. Interessante anche notare come lo status di prestigio palese e celato legato al dialetto si sia nel tempo di una generazione quasi sovvertito. Se nell’infanzia parlare in dialetto era in qualche modo censurato e collegato più o meno implicitamente a variazioni diastratiche, nella situazione attuale c’è un vero e proprio “ritorno a casa” nell’uso del dialetto, percepito dall’intera comunità sia a livello generazionale che sociale.
Nel nostro piccolo, con i video “Parole di memoria” cerchiamo di mantenere viva la memoria per saper riconoscere le nostre radici e per non perderle. Attraverso le parole del dialetto recuperiamo i ricordi e l’identità del territorio, che è anche la nostra. Mi piace richiamare il fatto che i greci avessero due termini per il ricordo: mneme e anamnesis, il primo per indicare il ricordo come ciò che appare, il secondo come oggetto di una ricerca, di una reminiscenza. Ma, in fondo, il senso del camminare nel ricordo è sempre proprio del soggetto, di chi cercando il “cosa”, attraverso il “come”, incontra il “chi”, ovvero “se stesso”, sia esso un “sé” individuale o collettivo: dal ricordo alla memoria riflessiva attraverso la reminiscenza. (Ricouer 2003)
L’uomo transitante e il patrimonio linguistico di una comunità
La tesi che si vuole suggerire nasce da un’osservazione sorta nel camminare tra le strade del territorio, prendendo atto di come il territorio sia un’entità “parlante”. Che lingua parla il territorio? Dove sono fisicamente collocate e reperibili le parole del territorio? Che cosa racconta attraverso le sue parole? Cosa tramanda? Cosa dovremmo saper ascoltare, per muovere con identità libera attraverso le transizioni del nostro tempo, di cui siamo soggetti attivi e critici, ma a cui rischiamo parzialmente di andar soggetti? La lingua, come la sociolinguistica ci insegna, non ha sola funzione pragmatica, ma ha anche l’aspirazione di conferire identità sociale e riconoscimento comunitario al parlante. Cosi le sue varietà ci permettono di comunicare chi siamo e di rendere le nostre scelte linguistiche pieno strumento di consapevolezza ed espressione del sé. (Santipolo 2022) Riacquistare conoscenza del dialetto e competenza comunicativa sembra essere un atto libero di resistenza e immaginazione culturale per i nostri territori. Linguisticamente parlando, un territorio dovrebbe poter conservare memoria di sé attraverso la lingua che ne racconta non solo l’evoluzione culturale, ma anche le radici antropologiche. La pregnanza del dialetto è nel descrivere e nel definire cose che, se anche non esistono nel presente, informano il nostro codice genetico socio-culturale e identitario. In questo le Parole di memoria hanno la capacità di rievocare e riattivare esperienze di riconoscimento e immaginazione, per il presente e per il futuro.
Riferimenti bibliografici
RICOEUR P. (2003), La memoria, la storia, l’oblio Raffaello Cortina Editore, Milano.
SANTIPOLO M. (2022), Educazione e politica linguistica. Teoria e pratica, Bulzoni Editore, Roma.
VENTURI P., ZANDONAI F. (2019) DOVE. La dimensione di luogo che ricompone impresa e società, Edizioni Egea, Milano.
- articolo pubblicato in Saperi Territorializzati, giugno 2023